RUGGERO GUARINI
Se hai un intelletto e un cuore, mostra solo uno dei due.
Te li maledicono se li mostri insieme.
HÖLDERLIN
![]() In ciò che Adorno dice della musica di Mahler (essa sembra a tratti realizzare ciò che per una vita intera ha sperato lo sguardo puntato dalla terra al cielo… promette qualcosa di diverso, promette di fendere un velo… aizza all’ira chi è complice del mondo così com’è ricordando ciò che costoro devono scacciare da se stessi… Fa sua la causa contro il corso del mondo, lo imita per accusarlo, e i momenti in cui vi fa breccia sono anche quelli della protesta… non rabbercia mai la frattura fra soggetto e oggetto e piuttosto che fingere una conciliazione raggiunta preferisce frantumarsi…), si afferma una concezione dell’arte che si propone di coglierne in pari tempo l’essenza e la genesi storica.
In ciò che Adorno dice della musica di Mahler (essa sembra a tratti realizzare ciò che per una vita intera ha sperato lo sguardo puntato dalla terra al cielo… promette qualcosa di diverso, promette di fendere un velo… aizza all’ira chi è complice del mondo così com’è ricordando ciò che costoro devono scacciare da se stessi… Fa sua la causa contro il corso del mondo, lo imita per accusarlo, e i momenti in cui vi fa breccia sono anche quelli della protesta… non rabbercia mai la frattura fra soggetto e oggetto e piuttosto che fingere una conciliazione raggiunta preferisce frantumarsi…), si afferma una concezione dell’arte che si propone di coglierne in pari tempo l’essenza e la genesi storica.
Decisivo, in essa, è il rifiuto di considerare l’estetica una branca separata del sapere. L’arte è sì un prodotto della divisione del lavoro estesa al linguaggio, ma proprio per questo ogni dottrina che pretenda di identificarne il senso occultando la frattura che l’ha generata, si lascia sfuggire il meglio: il movimento stesso della cosa, che si vorrebbe in fondo arrestare mediante una mera definizione di genere. Parlare sul serio dell’arte vuol dire parlare dell’uomo.
Non si dà un’estetica che non sia anche un’antropologia. Di fronte all’alta esigenza che il pensiero di Adorno si sforza di preservare in tempi ostili ad una riflessione che ignori gli artificiali steccati fra i quali prospera il sapere amministrativo, i diversi e ricorrenti tentativi di fondare un’estetica scientifica si rivelano per quel che sono: trionfa in essi la pretesa di estendere all’arte lo stesso trattamento che il dominio, di cui quella invoca da sempre il superamento dialettico, infligge alla natura e alla natura nell’uomo.
Allo sforzo di soggiogare il mondo naturale, che è il fine in cui tutte le moderne ideologie si riconoscono affini e
![]() solidali, corrisponde puntualmente il tentativo di applicare anche all’arte, figlia di quella violenza e promessa pervicace della conciliazione, la camicia di forza di quella ratio scientifica che già servì a ridurre la natura a semplice oggetto di sfruttamento.
solidali, corrisponde puntualmente il tentativo di applicare anche all’arte, figlia di quella violenza e promessa pervicace della conciliazione, la camicia di forza di quella ratio scientifica che già servì a ridurre la natura a semplice oggetto di sfruttamento.
Si vorrebbe cogliere il senso dell’arte mediante concetti costituentisi, per progressiva astrazione, come semplice unità delle caratteristiche degli oggetti da essi abbracciati (l’insieme noto delle singole opere d’arte), laddove l’arte, rinviando al suo contrario, non si lascia penetrare da un pensiero che, piegandosi docilmente al metodo e ai divieti delle scienze giurate su oggetti separati, ignora quella forza della contraddizione che sola potrebbe permettergli di risolvere l’oggetto nel suo movimento antitetico.
Quest’esigenza è assai più radicale di quella postulata dallo strutturalismo, anche dove quest’ultimo pone fra i suoi programmi quello di esaminare le interrelazioni fra sistemi che mutano o variano in rapporto ai reciproci condizionamenti, purché a livello teorico si sia unificato l’apparato dei concetti e delle categorie metodologiche.
Alla ricerca interdisciplinare, ammessa dal metodo strutturale, ma in cui sembra prolungarsi la falsa continuità del pensiero concettuale-classificatorio, Adorno contrappone il pensiero dialettico, aperto a quelle « intuizioni » che non sono né così irrazionali né così rapsodiche come ritengono lo scientismo e insieme anche Bergson, ma in cui esplode al contrario quel tanto di sapere migliore che è sfuggito all’apparecchiatura della scienza organizzata, e in cui affiora un sapere inconscio, non del tutto soggetto ai meccanismi di controllo; atti conoscitivi che, non avendo parte alcuna al lavoro manipolativo della conoscenza pilotata dall’Io, si ricordano in maniera passivo-spontanea di quegli elementi che irritano il pensiero ordinatore; conoscenze balenanti all’improvviso, sature di ricordo e di sguardo precorritore, che strappano l’individuo all’uniformità del mero sussumere riattualizzando nella sua coscienza conclusioni e giudizi passati, e soprattutto relazioni la cui riunione mette in luce quell’elemento dell’oggetto che è più del posto spettantegli nella sistematica.
Inutile obiettare che qui manca una riduzione del metodo a un principio certo e indubitabile: tutto il pensiero di Adorno è proprio una protesta ininterrotta contro il pregiudizio sistematico, contro quella costrizione a porre alla base di tutte le determinazioni del pensiero un che di fissato e di ultimo. L’elemento costrittivo del pensiero sistematico non è infatti che l’espressione della costrizione reale alla quale si piega il pensiero che nel suo accecamento la ritiene sua.
La scepsi adorniana verso la scelta di un assolutamente Primo come scelta di un punto di partenza indubitabile è dunque essenzialmente una rivolta contro i divieti e le coercizioni di un metodo che riprende nella sfera del pensiero le coercizioni della società antagonistica. Adorno fa invece sua la dottrina hegeliana della «mediatezza di ogni immediatezza » e coerentemente si oppone sia all’ideale corrente della scienza, sia alla pretesa (Husserl) di restaurare la prima philosophia in virtù della riflessione sullo spirito parificato da ogni traccia del mero ente.
La filosofia che cede a questa tentazione precipita in un abisso senza fondo. L’intuizione stessa non è un principio primo, una fonte assoluta della conoscenza separata dal pensiero discorsivo da un abisso ontologico, bensì una macchia oscura nel processo della conoscenza, dal quale tuttavia non può essere asportata, un atto che infrange la compatta concatenazione del procedimento deduttivo, uno strappo discontinuo in cui, sedimentato e sotto forma di ricordo di secondo grado, penetra tutto ciò che è all’opera nella conoscenza razionale per rivolgersi per un attimo contro l’apparato di cui il pensiero non sa valicare da solo l’ombra.
Se l’arte, come dice Schelling, comincia dove il sapere ci pianta in asso, nessuna sistematica che muova dai metodi delle discipline vigenti, anche se aperta alla ricerca interdisciplinare, può ambire a coglierne il senso. Anche l’esame delle interrelazioni fra territori più o meno contigui mercé l’unificazione delle categorie allestite dalle varie branche autorizzate del sapere, può solo contribuire, come una specie di taylorismo dello spirito, a migliorare i metodi produttivi delle scienze approvate, a razionalizzare l’accumulazione delle conoscenze, a evitare lo spreco di energie intellettuali in un ambito in cui il pensiero continua a farsi governare rimettendosi completamente al controllo da parte dell’organizzazione e lasciandosi prescrivere soltanto quei compiti di ricerca che si lascino assolvere con i mezzi dell’apparato disponibile.
Ecco perché a un sapere che accetti fino in fondo la trasformazione della filosofia in scienza (sia come «scienza delle scienze», sia come «scienza fra le scienze») il problema della natura dell’arte appare improponibile: il pensiero scientificizzato, innalzando a suo unico criterio l’ordine logico-classificatorio, vede nell’arte un « dato » recalcitrante e indigesto che aspetta invano di avere un posto nella trama compatta e severamente organizzata del sistema delle scienze collegate (e, qualora un posto non si trovi viene gettato via…) .
Ciò prova davvero che dove è l’arte, la scienza deve ancora arrivare. Per avvicinarsi al suo oggetto, il pensiero estetico dovrà perciò superare quell’ideale della scienza che, dopo aver aiutato la filosofia a liberarsi dai ceppi teologici, è divenuto anch’esso un ceppo che proibisce al pensiero di pensare; né per far ciò potrà rinunciare a quel poco di immaginazione che gli resta a disposizione nell’epoca della sua massima depurazione e del suo divorzio pressoché completo dall’esperienza sensibile.
Se l’arte presuppone, com’è ovvio, la separazione di immagine e segno, lo scindersi del linguaggio in linguaggio scientifico (segno) e linguaggio poetico (immagine), il pensiero potrà penetrarla solo sforzandosi di perpetuare il ricordo e l’esigenza di quell’unità originaria. Ciò è superiore alle forze del pensiero scientificizzato, che sa solo ridurre il suo oggetto a una pura e semplice funzione dello schema del quale sovranamente lo riveste ; non però del pensiero che non nasconde a se stesso la mutilazione che lo affligge, la ferita che lo ha generato; non del pensiero memore del contrario di cui è figlio non meno che dell’esito a cui tende (l’unità originaria di immagine e segno); non del pensiero dialettico nel cui movimento si esprime il movimento stesso della vita che invoca la conciliazione.
Nei suoi momenti migliori, lo strutturalismo si è certo avvicinato molto alla comprensione di questa esigenza. Quando Lévi-Strauss, discutendo con Sartre, respinge per esempio la pretesa di attribuire alla ragione dialettica una realtà sui generis (di erigerla, cioè, ipostatizzandola, a organo separato ed autonomo di un sapere privilegiato, indipendente dalla ragione analitica, sia come sua antagonista, sia come ad essa complementare), egli enuncia infatti un rifiuto analogo a quello espresso da Adorno quando contesta il pregiudizio, tipico dell’intuizionismo irrazionalista come dello stesso positivismo scientista, per cui tra il conoscere intuitivo e il pensiero discorsivo si aprirebbe un abisso incolmabile.
Per Lévi-Strauss, infatti, l’opposizione tra le due ragioni è relativa, non assoluta; corrisponde a una tensione, in seno al pensiero umano, che di fatto forse sussisterà indefinitamente, ma che in linea di diritto non è fondata. Per noi, la ragione dialettica è sempre costituente: è la passerella di continuo prolungata e migliorata che la ragione analitica lancia sopra un baratro di cui non scorge l’altra sponda pur sapendo che esiste, anche se essa dovesse costantemente allontanarsi.
Il termine ragione dialettica cela dunque il continuo sforzo che la ragione analitica deve fare per riformarsi, se pretende di rendere conto del linguaggio, della società e del pensiero; e la distinzione fra le due ragioni, a nostro modo di vedere, è fondata soltanto sul temporaneo scarto che separa la ragione analitica dall’intelligenza della vita. Sartre chiama la ragione analitica la ragione pigra; noi chiamiamo dialettica la stessa ragione, ma coraggiosa: curva nello sforzo che esercita per superarsi.
È dubbio, tuttavia, che lo strutturalismo, come scuola organizzata e tendenza filosofica mirante all’esercizio di un’egemonia culturale e ideologica, abbia sempre tenuto onore al programma enunciato in questo eccezionale e chiarificatore intervento del suo teorico più prestigioso. Quanti dei molti studiosi che praticano oggi il metodo strutturale, nell’accingersi a ridurre ad unità due o più diversi gruppi di fenomeni riconducendoli tutti alla struttura comune che li comprende e li spiega, sogliono ad esempio rispettare le due condizioni che, secondo Lévi-Strauss, rendono attuabile e legittima la riduzione stessa?
La prima di esse consiste nel non impoverire i fenomeni sottoposti a riduzione, nell’avere la certezza che si sia preliminarmente raccolto intorno a ciascuno tutto quel che contribuisce alla sua ricchezza e originalità distintiva. La seconda (di gran lunga più importante, poiché non s’esaurisce come l’altra nella norma in fondo ovvia della probità scientifica), consiste invece nell’essere preparati a vedere ogni riduzione sconvolgere da cima a fondo l’idea preconcetta che ci si poteva fare del livello, qualunque esso sia, che si cerca di raggiungere.
Le ulteriori precisazioni di Lévi-Strauss sono infine fondamentali, poiché mai come in esse lo strutturalismo si è esposto alla « critica immanente » dell’avversario, lasciandosi condurre, con le sue stesse forze, là dove forse esso stesso non vorrebbe a nessun costo pervenire:
L’idea di un’umanità generale, a cui la riduzione etnografica conduce, non avrà più nessun rapporto con quella che ce ne facevamo prima. E il giorno in cui si riuscirà a capire la vita come una funzione della materia inerte, sarà per scoprire che quest’ultima possiede proprietà ben diverse da quelle che le attribuivamo anteriormente. Non si possono quindi classificare i livelli di riduzione in superiori e inferiori, perché bisogna anzi aspettarsi che, per effetto della riduzione, il livello considerato superiore comunichi retroattivamente qualcosa della sua ricchezza al livello inferiore a cui lo si sarà ricondotto.
Rare volte l’impostazione strutturalistica si è offerta con pari lealtà alla critica di chi vuole estorcerle il suo momento di verità. Se, come dice Hegel nella Scienza della Logica, « una veritiera confutazione deve penetrare nelle forze dell’avversario e prender posizione nell’ambito della sua capacità, poiché attaccarlo al di fuori di lui stesso e aver ragione là dove egli non è, non apporta alcun vantaggio», bisognerà approfittare dei varchi che lo strutturalismo lascia aperti nella sua compagine teorica.
Sotto il velo di un linguaggio circospetto e solo in apparenza meramente riferitivo, Lévi-Strauss allude, nell’ultimo passo citato, a qualcosa che a nostro avviso è intimamente estraneo alla vocazione centrale dello strutturalismo. Detto in termini più elementari, vi si sostiene che la materia, la natura e insomma l’inferiore, risulteranno alla fine assai meno poveri e inerti di quanto non ci appaiono attraverso le maglie della rete ordita finora dalla ragione analitica.
Le limitate verità di quest’ultima ci sembreranno allora poco più che pregiudizi. L’uomo, per liberarsene, dovrà lasciar cadere la corazza antropocentrica; e proprio scoprendo come in lui stesso, nella sua carne misconosciuta e alienata, si prolunghi quella natura che nei suoi gradi supposti inferiori gli era sembrata inerte, adempirà la promessa storica della sua rigenerazione. Per quanto possa sembrare incredibile, i rigori strutturalistici, almeno nell’autore de La pensée sauvage, celano a volte qualcosa che somiglia molto a un elemento vitalistico.
Ma si tratta di un impulso che lo strutturalismo evita di approfondire, o che addirittura esso tende ad eludere, con una cautela che è il sintomo di una tenace resistenza interna. Proprio di fronte al problema dei rapporti fra i diversi gradi della vita, vengono infatti alla luce tutte le sue insufficienze. La più grave delle quali, a nostro avviso, è da individuarsi nella disinvoltura con cui esso sorvola sul ruolo e sugli effetti della repressione nella storia della cultura.
Lo strutturalismo, in altri termini, dopo aver riabilitato la natura sostenendo l’impossibilità di una classificazione graduata dei « livelli » si limita poi a postulare fra natura e cultura, fra livelli supposti « inferiori » e livelli supposti « superiori », un rapporto di mera continuità e analogia, eliminando spensieratamente quel momento del conflitto e dell’attrito che fa dell’inferiore non solo qualcosa che si prolunga nella cultura e che le fornisce la necessaria energia, ma anche un elemento col quale la cultura istituisce un rapporto di opposizione, e che essa, al vertice del proprio accecamento, vorrebbe addirittura negare.
Proprio da questa tendenza dello strutturalismo deriva peraltro la sua inadeguatezza di fronte ai fenomeni storici, ai quali esso aspira ad applicare i metodi delle scienze naturali, perpetuando in tal modo il mito durkheimiano di un’antropologia che sarebbe diventata tanto più rigorosa e scientifica quanto più avesse preso a proprio modello i metodi di quelle discipline. Di questa vocazione, al tempo stesso formalistica e naturalistica, dello strutturalismo, si potrebbero citare innumerevoli esempi.
Qui ci limiteremo a riferirne uno dei più estremi e paradossali: la proposta, suggerita da Lévi-Strauss nel suo saggio su Linguaggio e società, poi raccolto nel volume Anthropologie structurale, di estendere a tutti i fenomeni culturali quel metodo di indagine statistico-classificatorio che il Kroeber applicò con qualche successo allo studio dell’evoluzione dello stile femminile nel costume.
Kroeber, dunque, esaminò la moda, cioè un fenomeno sociale che Lévi-Strauss definisce giustamente come intimamente connesso all’attività inconscia dello spirito. Perché uno stile ci piace? E perché ad un certo punto cessa di essere di moda? Kroeber, com’è noto, mostrò come questa evoluzione, in apparenza arbitraria, obbedisca a leggi. Naturalmente, si tratta di leggi che non sono accessibili all’osservazione empirica, e nemmeno a un’apprensione intuitiva. Esse si manifestano, però, quando si misurino un certo numero di relazioni fra i diversi elementi del costume.
Tali relazioni sarebbero infine esprimibili nella forma di funzioni matematiche, i cui valori, calcolati a un dato momento, offrirebbero una base alla previsione. La moda — osserva a questo punto Lévi-Strauss —, cioè l’aspetto, a quanto si potrebbe credere, più arbitrario e contingente delle condotte sociali, è quindi passibile di uno studio scientifico. Ora, il metodo prospettato da Kroeber non soltanto assomiglia a quello della linguistica strutturale, ma lo si potrà utilmente accostare a talune ricerche delle scienze naturali, soprattutto a quelle del Tessier sulla crescita dei crostacei.
Questo autore ha mostrato come sia possibile formulare leggi di crescita, a condizione di fondarsi sulle dimensioni relative che compongono le membra (per esempio, le pinze) piuttosto che sulle loro forme. La determinazione di tali relazioni porta a stabilire parametri con l’aiuto dei quali possono essere formulate le leggi di crescita. La zoologia scientifica non ha dunque come oggetto la descrizione delle forme animali, così come sono percepite intuitivamente; si tratta soprattutto di definire relazioni astratte ma costanti, in cui appaia l’aspetto intelligibile del fenomeno studiato.
Lévi-Strauss, com’è noto, ha applicato un metodo analogo allo studio dell’organizzazione sociale, e soprattutto alle regole del matrimonio e dei sistemi di parentela. La validità e l’efficacia, entro certi limiti, di questo tipo di analisi, dev’essere ammessa senz’altro. Ciò che invece va contestato è la pretesa che l’individuazione di relazioni astratte e di regolarità ricorrenti in un dato fenomeno di crescita e di sviluppo, possa esaurire la comprensione del fenomeno stesso.
Anche ammesso che al livello dei fenomeni culturali si manifestino certe regolarità strutturali (come accade, appunto, per la rotazione delle forme della moda femminile, e come entro certi limiti può persino accadere che avvenga per la rotazione delle forme e degli stili nell’arte), la definizione di queste relazioni non ci dice ancora nulla sul « perché » di quei ricorsi e cangiamenti, cioè sul dinamismo e sul divenire della cultura.
Nell’arte arcaica, ad esempio, abbiamo l’alternarsi e il susseguirsi di naturalismo mimetico e di geometrismo ornamentale; in quella moderna, di classicismo e romanticismo, che si prolunga nelle sequenze impressionismo-cubismo, astrattismo geometrico-informale, espressionismo-neoplasticismo, etc.
Siamo forse soltanto di fronte a un divenire endogeno delle forme che si limita ad esporre nella diacronia leggi e relazioni che l’intelletto può cogliere nella loro essenza atemporale? Proprio questa è la pretesa dello strutturalismo, per il quale il mondo storico ridiventa il mondo platonico delle apparenze, l’imperfetto duplicato della sfera delle eterne idee-strutture. Ma le oscillazioni del gusto, la rotazione delle forme e degli stili, non si limitano a esporre delle regolarità intelligibili: esse tracciano piuttosto un movimento che riuscirebbe insensato e pleonastico, assurdamente ripetitivo e coatto, se non esprimesse, come ritiene il pensiero dialettico, l’insistenza pervicace di un impulso che tende ad affermarsi nella storia contro le resistenze che la storia stessa, con raddoppiata violenza, di volta in volta non cessa di opporgli.
Un aspetto di coazione non è certo estraneo alla vita dello spirito: ma le sue ripetizioni e regressioni, lungi dal rispecchiare la sua immutabile costituzione, sono soltanto la sua risposta coatta all’inestinguibile pressione di quell’elemento che vorrebbe liquidare. La storia non è affatto la semplice ripetizione della natura, ma l’elettrocardiogramma degli impulsi della natura conculcata per entro lo sviluppo repressivo della cultura.
L’arte è un momento della dialettica dell’illuminismo. Essa nasce, infatti, dalla sconfitta della magia e del mito, che l’illuminismo, perseguendo il programma di togliere agli uomini la paura e renderli padroni, si proponeva di rovesciare con la scienza. Ma l’illuminismo, alleandosi al dominio, si capovolge poi nel suo contrario: in strumento, appunto, del potere sulla natura e sugli uomini, in un « sapere » che è soprattutto « potere ».
Essenza di questo sapere è la tecnica, la quale non tende a concetti ed immagini, alla felicità della conoscenza, ma al metodo, allo sfruttamento del lavoro, al capitale privato o statale. Tutte le sue scoperte sono a loro volta strumenti. Ciò che gli uomini vogliono apprendere dalla natura è come utilizzarla ai fini del dominio della natura e degli uomini. Per Bacone, come per Lutero, la sterile felicità di conoscere è lasciva, al pari della natura animale.
Non in discorsi plausibili… ma nell’operosità e nel lavoro, e nella scoperta di particolari sconosciuti per un migliore equipaggiamento e aiuto nella vita risiede, secondo Bacone, il vero scopo e ufficio della scienza. Ciò che dunque importa non è quella soddisfazione che gli uomini chiamano verità, ma l’operation, il procedimento efficace.
È chiaro che Adorno intende, per illuminismo, l’orientamento pratico-strumentale impresso alla conoscenza e al pensiero nel passaggio dalla preistoria alla storia. In questo senso, l’impiego allargato della nozione di Aufklärung, proposta alla cultura moderna da lui e da Max Horkheimer, appare perfettamente legittimo.
L’illuminismo, in quanto pensiero essenzialmente orientato allo sfruttamento della natura e del lavoro umano, era certamente già all’opera molto prima che il padre della filosofia sperimentale ne raccogliesse ed enunciasse i motivi nel Novum Organum. Illuministici, addirittura, erano già i miti cosmologici che subentrarono alle più antiche concezioni magiche e animistiche.
I miti che cadono sotto i colpi dell’illuminismo sono sempre già il prodotto dell’illuminismo stesso. Le cosmologie presocratiche fissano il momento del trapasso. L’umido, l’indistinto, l’aria, il fuoco, che appaiono in essere come materia prima della natura, sono residui appena razionalizzati della conoscenza mitica… Da ultimo, con le idee di Platone, anche le divinità patriarcali dell’Olimpo, già separatesi dagli elementi come essenze dei medesimi, sono investite del logos filosofico…
Ma nell’eredità platonica ed aristotelica della metafisica, l’illuminismo riconobbe le antiche forze e perseguitò come superstizione la pretesa di verità degli universali. Persino nell’impulso che oggi porta le scienze a rinunciare al significato, a sostituire il concetto con la formula, la causa con la regola e la probabilità, continua ad affermarsi la tendenza che, già nel passaggio dall’animismo alle religioni solari e patriarcali, pose il cielo e la sua gerarchia al postodegli spiriti e dei dèmoni locali, e che in una fase ulteriore rimpiazzò gli stessi dèi molteplici con le categorie classiche della filosofia occidentale: sostanza e qualità, attività e passione, essere ed esistenza.
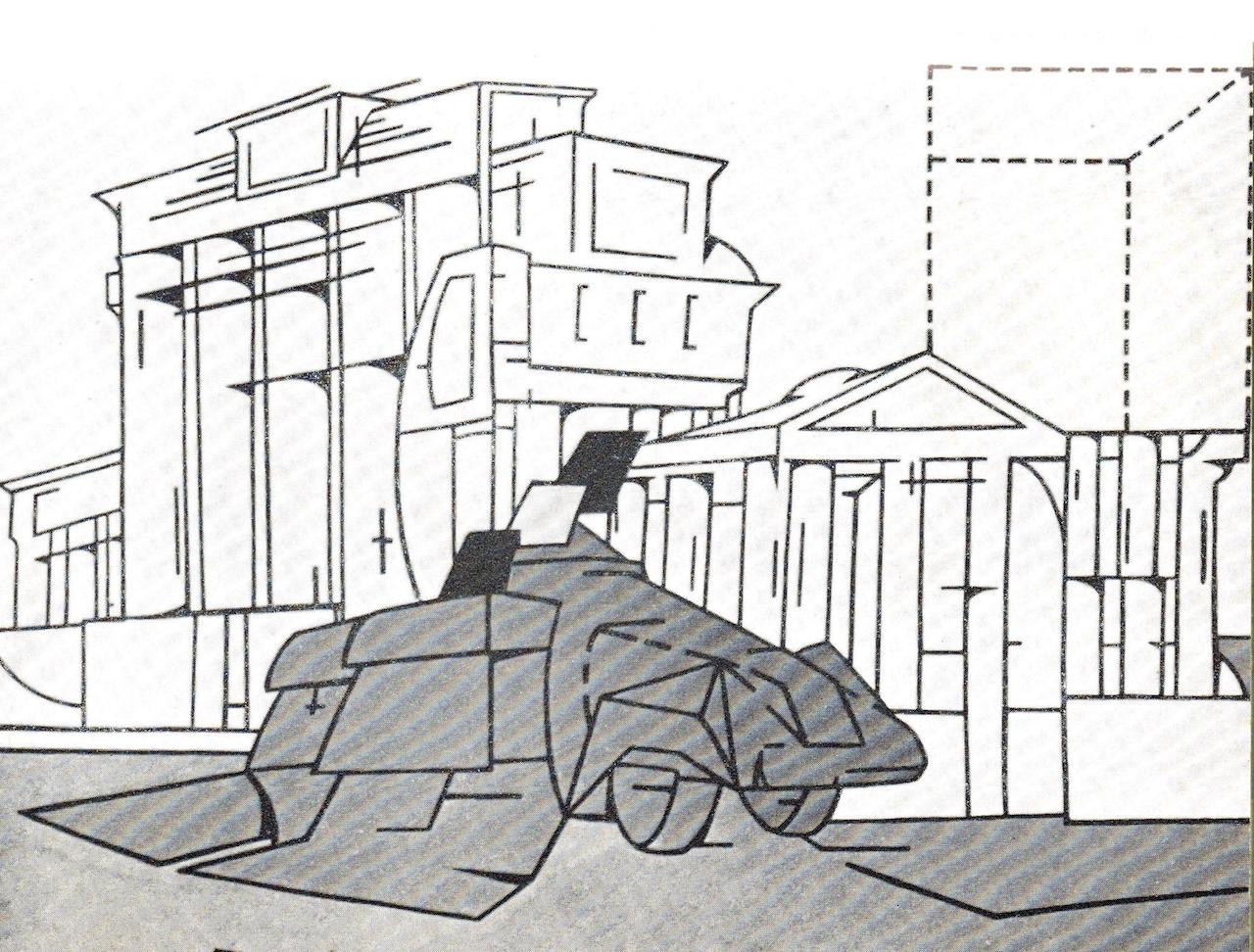
Così, in un processo senza fine tendente a far cadere ogni concezione teoretica determinata sotto l’accusa distruttiva di essere solo una fede, l’illuminismo, senza avvedersene, deve ogni volta misurarsi con se stesso, contestando ad ogni tappa della sua marcia le sue razionalizzazioni anteriori, bollando come « metafisica » i prodotti stessi dell’Aufklärung, finché anche i concetti di verità, di spirito e perfino di illuminismo, vengono relegati tra la magia animistica.
Se la filosofia, tollerata nei suoi luoghi deputati (le università e i cenacoli umanistici) come innocua speculazione e chiacchiera spensierata, continua a trastullarsi con le antiche categorie, la scienza ha ormai imparato da tempo a farne a meno, e il concetto di causa è stato l’ultimo concetto filosofico con cui la critica scientifica ha fatto i conti. L’illuminismo divora se stesso, è un permanente crepuscolo degli idoli, in cui il logos si afferma sempre più esclusivamente come mero spirito ordinatore, mentre la natura, parallelamente, trapassa in pura oggettività… sostrato del dominio… oggetto di pura suddivisione.
Ma come l’opera svolta a suo tempo dai miti era già essa stessa illuministica, così l’illuminismo, ad ogni passo, s’impiglia più profondamente nella mitologia. La categoria centrale del mito classico era quella del destino, del fato imperativo ed inviolabile, per cui nulla sarebbe potuto accadere agli uomini di sostanzialmente diverso da ciò che in anticipo era già scritto nel libro del destino. Nel cono di luce cruda proiettato da quella concezione, la vita si riduceva pertanto a una ripetizione e a una conferma del decreto mitico. Il positivismo scientista, con la sua adorazione del principio d’identità, afferma lo stesso concetto.
L’uno e l’altro pretendono che il «diverso» non deve essere che l’Altro deve dissolversi e scomparire nell’uniformità compatta dell’Identico. II principio d’immanenza, la spiegazione di ogni accadere come ripetizione, che l’ illuminismo sostiene contro la fantasia mitica, è quello stesso del mito. L’arida saggezza per cui non c’è nulla di nuovo sotto il sole e gli uomini sono condannati all’autoconservazione per adattamento, non fa che riprodurre la fantastica che respinge: la ratifica del destino, che ripristina continuamente, per contrappasso, ciò che già era.
Non solo con la natura, sì anche con gli uomini, l’astrazione, lo strumento dell’illuminismo, opera come il destino di cui elimina il concetto: come liquidazione. Gli uomini in quanto soggetti vengono liquidati dalla ratio ordinatrice e sistematica con lo stesso gesto autoritario della sentenza mitica. Nel corso progressivo della demitizzazione, essa identifica il vivente col non-vivente, e con ciò l’uomo si illude di liberarsi dalla paura che il vivente incompreso ha sempre suscitato in lui, inducendolo a vedere in esso la manifestazione portentosa di una forza occulta e proibita.
Ma la pura immanenza positivistica, ultimo prodotto dell’illuminismo, è anch’essa un divieto e una proibizione: non è che un tabù per così dire universale: non ha da esserci più nulla fuori poiché la semplice idea di un fuori è la fonte genuina dell’angoscia. Così l’illuminismo resta un prodotto di quella paura che avrebbe voluto dissolvere, ed anzi si rivela, essenzialmente, come l’angoscia mitica radicalizzata. Nell’odierna intolleranza del pensiero scientificizzato per ciò che non si lascia imprigionare nelle sue maglie, vibra ancora l’eco del grido di terrore con cui il primitivo esperiva l’insolito, la paura suscitata dalla strapotenza reale della natura nelle deboli anime dei selvaggi.
Certo, anche la magia, come la scienza che la soppianta, era rivolta a scopi, ma essa li perseguiva mediante la mimesi, non in un crescente distacco dall’oggetto. Nella fase magica, cioè, gli uomini non pagavano ancora l’accrescimento del loro potere con l’estraniazione da ciò su cui essi lo esercitavano; donde il carattere e l’efficacia simbolica del loro linguaggio, i cui elementi non erano considerati solo come un segno della cosa, ma erano uniti ad essa dalla somiglianza e dal nome. Questa funzione passò quindi ai miti, che, come i riti magici, intendono ancora la natura che si ripete, anima del simbolico. Gli dèi mitici, infatti, avevano ancora qualcosa del mana: incarnavano la natura come potere universale.
Ma al simbolismo mitico subentra infine l’universalità delle idee sviluppata dalla logica discorsiva; alle vecchie e confuse rappresentazioni dell’eredità magica, l’unità concettuale; e ciò, storicamente, avviene insieme alla fine del nomadismo ed al costituirsi di un nuovo ordinamento sulla base della proprietà stabile. Così dominio e lavoro si separano, il distacco del soggetto dall’oggetto ripete nella sfera del pensiero il distacco dalla cosa a cui il padrone perviene mediante il servitore, e il dominio nella sfera del concetto si eleva sulla base del dominio reale.
È in questa vicenda dialettica di mito e scienza, lavoro e dominio, che Adorno cerca di cogliere anche la genesi e il senso dell’arte. Questa gli sembra infatti ereditare dalla magia quell’impulso della conoscenza a cogliere effettivamente l’oggetto che fu bandito, insieme con la magia mimetica, dal pensiero calcolante e sistematico orientato al controllo e al dominio. Col proseguire di questo pensiero, mentre i miti si riducono a mere creazioni fantastiche, la divisione del lavoro si estende al linguaggio. Come segno, la parola passa alla scienza; come suono, come immagine, come parola vera e propria, viene ripartita fra le varie arti.
Ma le conseguenze sono paradossali, poiché sia la scienza che l’arte, serbando il ricordo dell’unità originaria, conservano alla radice anche l’impulso che si vorrebbe bandire da ciascuna di esse per assegnarlo in dote esclusiva all’altra. Vera scienza e vera arte sono quelle che non si lasciano mai del tutto governare dal principio della loro separazione. Se poi si consegnano a quel criterio fino in fondo, deperiscono entrambe, ciascuna nella falsa immagine dell’altra: come segno, il linguaggio deve limitarsi ad essere calcolo: per conoscere la natura, deve abdicare alla pretesa di somigliarle; come immagine, deve limitarsi ad essere copia: per essere interamente natura, abdicare alla pretesa di conoscerla.
L’antitesi corrente di arte e scienza, che le separa fra loro come settori culturali per renderle entrambe, come tali, amministrabili, le fa trapassare alla fine, in virtù delle loro stesse tendenze, l’una nell’altra. La scienza… diventa estetismo, sistema di segni assoluti, priva di ogni intenzione che la trascenda: diventa quel « gioco » in cui i matematici hanno fieramente affermato da tempo risolversi la loro attività. Ma l’arte della riproduzione integrale si è votata, fin nelle sue tecniche, alla scienza positivistica. Essa diventa, infatti, mondo ancora una volta, duplicazione ideologica, docile riproduzione. Col progredire dell’illuminismo, solo le opere d’arte genuine hanno potuto sottrarsi alla semplice imitazione di ciò che è già.
Sia Platone che la Bibbia bandiscono l’imitazione, il principio della magia, e con esso l’arte che lo eredita. Questa, per l’autore della Repubblica, è da condannarsi perché « inutile » (e, paradossalmente, per quel maleficio che è inerente all’Aufklärung, il positivismo muoverà la stessa accusa alla dottrina delle idee). Tutto l’odio della civiltà illuminata si rivolge all’immagine della preistoria superata e alla sua immaginaria felicità. La civiltà sancisce che non si deve influire sulla natura assimilandosi ad essa, ma … dominarla col lavoro.
In termini freudiani, è il trionfo del « principio di realtà ». Herbert Marcuse, allievo di Adorno e, come questi, oltre che nutrito di pensiero hegelo-marxista, conoscitore e critico profondo delle dottrine freudiane, intenderà a un dipresso la stessa cosa col suo « principio di prestazione ». Il decreto-divieto della civiltà non può essere adempiuto, in ogni caso, se non attraverso la formazione dell’Io, dell’identità del soggetto che può dominare la natura soltanto ponendo fra sé e quella una distanza.
Essenziale, in questo processo, è poi il fatto che la natura dalla quale l’Io si distacca non è solo quella esterna al soggetto, sì anche quella che si prolunga all’interno dell’individuo e che sopravvive in esso come insieme caotico e informe di impulsi inconsci. Chi vuol controllare la natura deve prima imparare a controllare se stesso, la violenza fatta a quella implica una violenza fatta a se stessi, il dominio del mondo esterno presuppone l’auto-dominio, e tutto questo è opera dell’Io, pilota del pensiero utilitario ed organo dell’autoconservazione.
Ma che cosa l’opera d’arte ha ancora in comune con la magia? Il fatto di istituire un cerchio proprio e in sé concluso, che si sottrae al contesto della realtà profana, e in cui vigono leggi particolari. Come il primo atto del mago nella cerimonia era quello di definire e isolare, da tutto il mondo circostante, il luogo in cui dovevano agire le forze sacre, così, in ogni opera d’arte, il suo ambito si stacca nettamente dalla realtà. Proprio la rinuncia all’azione esterna, con cui l’arte si separa dalla simpatia magica, ritiene tanto più profondamente l’eredità della magia. Essa mette la pura immagine a contrasto con la realtà fisica, di cui l’immagine riprende e custodisce gli elementi.
Il contesto della realtà profana da cui si stacca l’opera d’arte è evidentemente quello stesso in cui domina l’Io pratico. Per un istante il soggetto torna pertanto ad abolire, nell’operare artistico, la distanza che esso ha posto fra il soggetto e la natura. È infine nel senso dell’opera d’arte, nell’apparenza estetica, essere ciò a cui dava luogo, nell’incantesimo del primitivo, l’evento nuovo e tremendo: l’apparizione del tutto nel particolare. Nell’opera d’arte si compie ancora una volta lo sdoppiamento per cui la cosa appariva come alcunché di spirituale, come estrinsecazione del mana.
Ciò costituisce la sua « aura ». Come espressione della totalità, l’arte pretende alla dignità dell’assoluto: dove Adorno enuncia una fiducia nell’arte a cui il mondo borghese, da Platone ai moderni teorici dello stato totalitario, fu disposto solo di rado, riprendendola dalla dottrina di Schelling secondo la quale la separazione di immagine e segno viene « interamente abolita da ogni singola rappresentazione artistica ». Il « diverso » che l’arte promette è dunque la natura da cui la civiltà illuminata si estrania dominandola, ma la promessa riesce infine vana poiché il paradosso dell’arte è appunto che in essa la voce insaziabile della natura inconciliata venga neutralizzata a puro oggetto di contemplazione.
Come questa neutralizzazione del « canto » della natura nel « canto » dell’arte si attui ancora una volta attraverso il processo storico di separazione del dominio dal lavoro, Adorno lo mostra infine nella sua magistrale interpretazione del dodicesimo canto dell’Odissea, che narra, com’è noto, del passaggio di Ulisse davanti alle Sirene. L’importanza capitale di questo passo, vera chiave per la comprensione del pensiero estetico adorniano, esige una citazione integrale: La tentazione che esse (le Sirene) rappresentano, è quella di perdersi nel passato.
Ma l’eroe a cui la tentazione si rivolge, è diventato adulto nella sofferenza. Nella varietà dei piccoli mortali in cui ha dovuto conservarsi, si è consolidata in lui l’unità della vita individuale, l’identità della persona. Come acqua, terra ed aria, si scindono davanti a lui i regni del tempo. L’onda di ciò che fu rifluisce dalla roccia del presente, e il futuro campeggia nuvoloso all’orizzonte. Ciò che Odisseo ha lasciato dietro di sé, entra nel mondo delle ombre: il Sé è ancora cosi vicino al mito primordiale, da cui è uscito con immenso sforzo, che il suo stesso passato, il passato direttamente vissuto, si trasforma in passato mitico.
A questo egli cerca di rimediare con un solido ordinamento del tempo. Lo schema tripartito deve liberare l’attimo presente dalla potenza del passato, ricacciando quest’ultimo dietro il confine assoluto dell’irrecuperabile, e mettendolo, come sapere utilizzabile, a disposizione dell’ora. L’impulso di salvare il passato come vivente, anziché utilizzarlo come materia del progresso, si placava solo nell’arte, a cui appartiene anche la storia come rappresentazione della vita passata. Finché l’arte rinuncia a valere come conoscenza, escludendosi così dalla prassi, è tollerata dalla prassi sociale come il piacere.
Ma il canto delle Sirene non è ancora depotenziato e ridotto a pura arte. Rievocando direttamente un passato recentissimo, esse minacciano, con l’irresistibile promessa di piacere con cui si annunzia e viene ascoltato il loro canto, l’ordine patriarcale che restituisce a ciascuno la sua vita solo contro il corrispettivo della sua intera durata temporale. Chi cede ai loro artifizi è perduto, mentre solo una costante presenza di spirito strappa l’esistenza alla natura. Se le Sirene sanno di tutto ciò che accade, esse chiedono in cambio il futuro, e la promessa del lieto ritorno è l’inganno con cui il passato cattura il nostalgico.
La tentazione delle Sirene resta invincibile, e nessuno può sottrarvisi, ascoltando il loro canto. L’umanità ha dovuto sottoporsi a un trattamento spaventoso, perché nascesse e si consolidasse il Sé, il carattere identico, pratico, virile dell’uomo, e qualcosa di tutto ciò si ripete in ogni infanzia. Lo sforzo di tenere insieme l’io appartiene all’io in tutti i suoi stadî, e la tentazione di perderlo è sempre stata congiunta alla cieca decisione di conservarlo.
L’angoscia di perdere il Sé, e di annullare, col Sé, il confine tra se stessi e il resto della vita, la paura della morte e della distruzione, è strettamente congiunta ad una promessa di felicità da cui la civiltà è stata minacciata ad ogni istante. La sua vita fu quella dell’obbedienza e del lavoro, su cui la soddisfazione brilla eternamente come pura apparenza, come bellezza impotente. Il pensiero di Odisseo, ugualmente ostile alla propria morte e alla propria felicità, sa di tutto questo.
Egli conosce due sole possibilità di scampo. Una è quella che prescrive ai compagni. Egli tappa le loro orecchie con la cera e ordina loro di remare a tutta forza. È ciò a cui la società ha provveduto da sempre. Freschi e concentrati, i lavoratori devono guardare in avanti, e lasciar stare tutto ciò che è lato. L’impulso che li indurrebbe a deviare va sublimato — con rabbiosa amarezza — in ulteriore sforzo. Essi diventano pratici.
L’altra possibilità è quella che sceglie Odisseo, il signore terriero, che fa lavorare gli altri per sé. Egli ode, ma impotente, legato all’albero della nave, e più la tentazione diventa forte, e più strettamente si fa legare, così come, più tardi, anche i borghesi si negheranno più tenacemente la felicità quanto più, crescendo la loro potenza, l’avranno a portata di mano.
Ciò che ha udito resta per lui senza seguito: egli non può che accennare col capo di slegarlo, ma è ormai troppo tardi: i compagni, che non odono nulla, sanno solo del pericolo del canto, non della sua bellezza, e lo lasciano legato all’albero, per salvarlo e per salvare sé con lui. Essi riproducono, con la propria, la vita dell’oppressore, che non può più uscire dal suo ruolo sociale. Gli stessi vincoli con cui si è legato irrevocabilmente alla prassi, tengono le Sirene lontano dalla prassi: la loro tentazione è neutralizzata a puro oggetto di contemplazione, ad arte.
L’incatenato assiste ad un concerto, immobile come i futuri ascoltatori, e il suo grido appassionato, la sua richiesta di liberazione, muore già in un applauso. Così il godimento artistico e il lavoro manuale si separano all’uscita dalla preistoria. L’epos contiene già la teoria giusta. Il patrimonio culturale sta in esatto rapporto col lavoro comandato e l’uno e l’altro hanno il loro fondamento nell’obbligo ineluttabile del dominio sociale sulla natura.
3
La tesi per cui l’arte sarebbe innanzitutto l’espressione della nostalgia dell’uomo illuminato per il perduto rapporto mimetico con la natura, coincide puntualmente con alcune note acquisizioni della sociologia dell’arte.
La vecchia e opposta tesi esposta da Gottfried Semper in Der Stil in den technischen und architektonischen Künsten, secondo la quale l’arte non è che un derivato del mestiere e la quintessenza di quelle forme decorative che risultano dalla natura del materiale, dai processi della lavorazione e dall’ uso a cui è destinato l’oggetto, sembra infatti essere stata superata definitivamente dalle ricerche di Alois Riegl, per il quale all’origine di ogni arte, anche se ornamentale, sta l’imitazione della natura, mentre le stesse forme geometricamente stilizzate non sarebbero, nella storia dell’arte, un fenomeno iniziale, ma relativamente tardo, frutto di una sensibilità artistica già molto raffinata.
La tesi meccanico-materialistica del Semper è stata poi respinta dallo stesso Hauser, per il quale l’arte, inizialmente, è soprattutto uno strumento della devozione alla natura. Anche l’idea che nell’arte sopravviva un principio ereditato dalla magia trova un riscontro preciso nell’analisi di Hauser, dove il naturalismo paleolitico – che già possiede, apparentemente senza sforzo, quell’unità dell’intuizione sensibile a cui l’arte moderna giunge soltanto dopo una lotta secolare – è descritto essenzialmente come lo strumento di una prassi magica, per cui le immagini di quella pittura sono insieme rappresentazione e cosa rappresentata, desiderio e appagamento.
Nell’immagine da lui dipinta il cacciatore paleolitico credeva di possedere la cosa stessa, credeva, riproducendo, di acquisire un potere sull’oggetto. Egli credeva che l’animale vero subisse l’uccisione eseguita sull’animale dipinto. La rappresentazione figurata non era, secondo la sua idea, che l’anticipazione dell’effetto desiderato; l’avvenimento reale doveva seguire il modello magico; o, piuttosto, esservi già contenuto, perché le due cose erano separate soltanto dal mezzo, ritenuto inessenziale, dello spazio e del tempo.
Per l’uomo paleolitico, cioè, il mondo delle finzioni e delle immagini, la sfera dell’arte e della pura imitazione, non significavano ancora un campo specifico, distinto e separato dalla realtà empirica; egli non confrontava ancora i due mondi, ma vedeva nell’uno la immediata prosecuzione dell’altro. In ogni caso, le due antichissime idee che sono i primi presupposti dell’arte, l’idea della somiglianza e dell’imitazione, e quella della produzione dal nulla, ossia della potenza creativa, sono in pari tempo i presupposti della magia in quanto pratica al servizio della vista perseguente i suoi scopi, come chiarisce Adorno, mediante la mimesi anziché in quel crescente distacco dall’oggetto con cui l’uomo illuminato paga il suo accresciuto potere sulla natura.
Resterebbe da chiedersi se sia propriamente legittimo chiamare già « arte » tipi di linguaggio ancora perfettamente integrati in una prassi magica, com’è appunto il caso dell’arte paleolitica. Poiché si è detto che l’arte nasce dalla scissione del linguaggio in immagine e segno, l’ossequio a un astratto rigore nomenclativo dovrebbe vietarci di farlo. Ma allora dovremmo ugualmente, in linea di principio, astenercene in tutti quei casi in cui degli esiti estetici risultino raggiunti nel quadro di un’attività essenzialmente orientata ad altro e dalla quale, a meno di non credere a un superficiale estetismo, non si lasciano distaccare.
Per fare un esempio banale, il problema si riproporrebbe in termini pressoché identici per quasi tutta l’arte medievale, i cui valori estetici, essendo organicamente integrati con tutti gli altri elementi dell’opera in una concezione cosmologica unitaria e in uno stile di vita che modellava fin nei più minuscoli dettagli la stessa esistenza quotidiana degli uomini, esigono ben altro, per essere realmente penetrati, che una « degustazione » separata e specialistica.
In realtà, già il semplice porre il problema equivale a ricadere in pieno nel nefasto pregiudizio dell’art pour l’art. E infatti, al livello delle poetiche operative, l’art pour l’art è l’esatto equivalente della pretesa, a livello teorico, di definire e isolare il territorio proprio dell’arte selezionando le supposte proprietà comuni di una collezione data di oggetti estetici. I circoli viziosi e tautologici a cui mettono capo simili tentativi sono fin troppo noti. In base a quale criterio selezioneremo gli oggetti dai quali pretendiamo di ricavare, per semplice via di astrazione, le proprietà che li rendono tali?
Il pensiero estetico che s’irretisce in questi procedimenti analitici ignora che la parola « arte », in realtà, non è di quelle che rinviano a una mera determinazione dell’intelletto astratto, a un insieme finito o infinito di elementi raggruppabili in base a una o più caratteristiche comuni: è un concetto essenzialmente dialettico, una di quelle idee in cui si deposita (come nelle idee di « libertà », «giustizia», «umanità»), l’intera esperienza storica del progressivo attuarsi di una concreta esigenza.
Per questo si può affermare, senza cadere in contraddizione, sia che l’arte eredita il principio della magia, sia che la magia contiene già il principio dell’arte: il che sembra coincidere, in parte, con quanto afferma anche Lévi-Strauss, là dove egli sostiene che l’arte si inserisce a metà strada fra la conoscenza scientifica e il pensiero mitico o magico.
Bisognerà evitare, tuttavia, di adoperare la definizione di Lévi-Strauss come una formula che tende a lasciarsi sfuggire il movimento interno dell’oggetto. E, soprattutto, occorre resistere alla tentazione, tipica dello strutturalismo, di postulare un’equivalenza meccanica dei diversi livelli studiati mercé la possibilità, più volte espressa dallo stesso Lévi-Strauss, di riferirli tutti alle modalità produttive di un eterno e immutabile « spirito inconscio » della specie, specchio a sua volta di una struttura ontologica.L’arte starà pure a mezza strada fra la scienza e il mito, ma non tutti i fili che attraversano un livello giungono agli altri due, o almeno non vi giungono, per cosi dire, illesi.
La scienza, ad esempio, se da un lato eredita dalla magia il principio pratico-strumentale, e insieme a questo il principio conoscitivo, non ne accoglie il principio mimetico, cioè la tendenza a conoscere l’oggetto in un massimo di aderenza al suo movimento naturale (non a caso, proprio laddove la scienza continua a utilizzare categorie e concetti che conservano ancora alcunché dell’immagine, parole semimagiche come « forza » ed « energia », l’epistemologia positivista l’accusa di continuare ad operare sulla base di taciti presupposti metafisici, e le rivolge quindi l’invito a sostituire quei concetti-immagini con concetti-schemi puramente operativi).
D’altra parte, lo stesso principio conoscitivo che si sviluppa nella scienza, separandosi dal principio mimetico e attuandosi appunto come conoscenza operativa, lascia inappagata un’esigenza che sarà accolta dall’arte anche e proprio come impulso ad una conoscenza « migliore », a un sapere basato non sul distacco, ma sull’aderenza all’oggetto, e quindi tanto più « vero » del sapere scientifico anche se, rispetto a questo, assolutamente inefficace ai fini utilitari dello sfruttamento dell’oggetto. Tutto l’itinerario che porta dal mito all’arte e alla scienza è insomma percorso da una tensione che la teoria della riducibilità dei livelli, con le sue implicazioni ontologiche, sembra impotente a cogliere. L’esser curva nello sforzo di superarsi non è solo, come sembra credere Lévi-Strauss, una proprietà della ragione dialettica, ma anche della vita che quella si sforza di comprendere.
Alla luce di queste considerazioni, il contributo centrale dell’antropologia strutturale — cioè l’accento posto con straordinario vigore sul carattere di organica e armoniosa compattezza di quelle civiltà che ci ostiniamo a chiamar primitive — può rivelarsi realmente fecondo. L’immagine di quelle civiltà dovrà essere ripresa non già come un oggetto offerto semplicemente alla nostra soddisfazione intellettuale ed estetica, bensì come la figura retrodatata di una finalità che è anche nostra, come il simbolo allusivo di quell’unità strutturale che anche noi, uomini storici, ci ripromettiamo di riguadagnare, come il modello su scala ridotta di un equilibrio a cui tendiamo, forse indefinitamente, noi stessi. Ciò può sembrare mitico.
Eppure è fuor di dubbio che tutto il nostro interesse per il mondo cosiddetto primitivo, interesse che sembra inestirpabile dalla cultura e che diventa sempre più intenso col progredire della nostra civiltà, corrisponde a ben altro che a una semplice curiosità dell’intelletto o del gusto. In esso si esprime una nostalgia, ed ogni nostalgia è sempre una tensione, un movimento-verso, dove il passato funge improvvisamente da cifra del futuro e bussola del presente. Qui è anche la ragione profonda del fascino che irradiano ancor oggi quei documenti delle civiltà primitive in cui i singoli aspetti del linguaggio — uso, funzione, segno, immagine — appaiono ancora uniti, come sa mostrare così bene Lévi-Strauss, nella compagine salda di un’attività totalizzante.
Egli esamina, ad esempio, una semplice clava tlingit di legno di cedro, adoperata dai pescatori d’Alaska per tramortire il pesce, e osserva che l’artista, scolpendola a forma di mostro marino, ha voluto che il corpo dello strumento si confondesse col corpo dell’animale, il manico con la coda, e che le proporzioni anatomiche attribuite a una creatura favolosa, fossero tali che l’oggetto potesse essere l’animale crudele, uccisore di vittime impotenti, e contemporaneamente un’arma ben calibrata, agevole da maneggiare ed efficace nei risultati. Sembra che tutto, dunque, sia strutturale in questo strumento che è pure una splendida opera d’arte: il simbolismo mitico come la funzione pratica. Più esattamente, la sua funzione e il suo simbolo sembrano ripiegarsi l’uno sull’altro e formare un sistema chiuso…
Ciò equivale a ricordare che l’arte, o la qualità estetica, presso quelle culture che si collocano storicamente prima della divisione del lavoro sulla base della proprietà stabile, è un elemento che penetra in tutti gli aspetti dell’esistenza umana. Il canto rituale del melanesiano che vara la sua nuova imbarcazione (ma lo stesso può dirsi di qualsiasi cerimonia analoga, dai riti d’iniziazione alle danze matrimoniali), è al tempo stesso un atto propiziatorio e quindi pratico, un rito sociale e quindi una funzione della vita collettiva, l’espressione di una concezione simbolica tendente ad assegnare un posto riconoscibile e significativo a tutti gli elementi del mondo umano e naturale, e, infine, un oggetto estetico le cui proprietà formali si saldano organicamente a tutti quegli altri aspetti, ricevendone un supplemento di forza.
Di qui il paradosso dell’arte che diventa il fine di se stessa: in essa, pur quando si distacca come attività separata nell’àmbito della società contrassegnata dalla divisione del lavoro, continua ad agire l’impulso a ripristinare quell’unità strutturale che emana ancora tutto il suo splendore dal più umile reperto etnologico.
Questi accenni ad un possibile confronto fra taluni aspetti del pensiero estetico adorniano e le considerazioni, tutt’altro che occasionali, sviluppate da Lévi-Strauss sulla natura dell’arte, sono evidentemente sommarî e insufficienti. Eppure, non foss’altro per il fatto che questi due studiosi, di così diverso orientamento ma entrambi di squisita formazione filosofica, abbiano ugualmente individuato nei rapporti che l’arte intrattiene da un lato col mito, dall’altro con la scienza o con l’illuminismo, il punto focale su cui deve convergere l’indagine, delineando in tal modo un passaggio sull’abisso che la cultura borghese ha scavato fin dal suo nascere fra l’intelletto e la sensibilità, uno studio accurato dei punti di contatto e di opposizione fra le teorie dell’uno e dell’altro potrebbe riuscire estremamente fecondo.
A integrare in via del tutto provvisoria queste lacunose osservazioni, qui aggiungeremo soltanto che, a nostro avviso, ciò che sembra sfuggire a Lévi-Strauss e ciò che tuttavia sembra sfuggire al critico strutturalista, è l’impossibilità oggettiva, nelle condizioni della civiltà moderna, e quindi nell’àmbito di una cultura che continua a svilupparsi sulla base della scissione di segno e immagine, comunicazione ed espressione, arte e scienza, di opere segnate da quella compattezza strutturale che egli ammira giustamente in tutti i documenti dell’arte arcaica.
Della clava tlingit di cui parla nel brano che abbiamo citato, Lévi-Strauss, per precisarne il carattere di struttura chiusa, aggiunge che in essa, come in ogni prodotto dell’arte primitiva, l’evento non ha alcuna possibilità di introdursi , dove per evento egli intende l’accidentalità e la contingenza che irrompe dall’esterno nella struttura dell’opera.
Ai documenti dell’arte arcaica egli contrappone quindi, a titolo di esempio, il famoso ritratto di Elisabetta d’Austria del Clouet, di fronte al quale egli osserva che si realizza un genere di emozione estetica radicalmente diverso da quello suscitato dalla clava tlingit, dipendente appunto non già dalla chiusura del sistema, ma dall’unione tra l’ordine della struttura, rappresentato dalla riproduzione filo per filo di una gorgerina di pizzo in uno scrupoloso trompe-l’oeil, e l’ordine dell’evento, rappresentato a sua volta dal contrasto fra il biancore della gorgerina e i colori delle altre parti del vestito, il riflesso del collo madreperlaceo che essa cinge e quello del cielo di un dato giorno e di un dato momento.
Lévi-Strauss non si chiede, tuttavia, quali sono le condizioni socio-culturali di fondo che hanno consentito, nel primo caso, la realizzazione di un’opera chiusa e che, nel secondo, hanno al contrario invocato quella che egli chiama l’introduzione dell’evento nella struttura. A nostro avviso, ciò accade, sostanzialmente, perché la cultura nel cui seno furono creati oggetti come la clava tlingit, non essendosi ancora radicalmente estraniata dalla natura-evento, non aveva poi bisogno di reintrodurla in una struttura che rispecchiava appunto un equilibrio fondato tuttora sull’aderenza al mondo naturale.
D’altra parte, dal semplice dato di fatto che in tutta l’arte moderna non v’è una sola grande opera che non realizzi appunto, come il quadro del Clouet, l’introduzione dell’evento, e il cui fascino non nasca proprio da una simile effrazione della struttura (il che accade persino in quegli artisti che si sogliono per convenzione considerare « classici » : il caso di Mozart è flagrante), sembriamo portati a concludere che nel raggio della cultura moderna, sempre a causa della frattura di cui essa reca il marchio, la totalità della vita possa, per così dire, « riapparire », al livello del fare artistico, proprio e soltanto infrangendo la compattezza della struttura, in cui si rispecchiano la coercizione e il dominio, con l’introduzione dell’evento, della contingenza, dell’accidentalità, in cui si esprime al contrario il libero impulso del soggetto.
Lo strutturalismo, tuttavia, evita abitualmente di pervenire a tanto. Vedremo comunque fra breve che il concetto di effrazione della forma, di irruzione dell’Altro nella struttura, è una categoria centrale nel pensiero estetico di Adorno.
La differenza fra le due teorie pare pertanto risiedere principalmente in questo: mentre per Lévi-Strauss l’arte arcaica e l’arte moderna (l’una basata sull’assenza dell’evento e sul predominio totale della struttura; l’altra, invece, sull’integrazione dell’evento e, addirittura, sull’accento posto con energia sull’aspetto eventico) sembrano costituire i due estremi di un movimento pendolare dell’arte tuttora in atto, sicché in esse si affermerebbero, allo stato più o meno puro, due principi ancor vivi ed attivi nell’operareartistico moderno, per Adorno, invece, la possibilità di un’arte degna di questo nome che sacrifichi del tutto l’evento alla struttura, è attualmente del tutto preclusa.
L’arte che non accoglie l’evento, per Adorno, è ideologia e menzogna, poiché nelle condizioni della cultura moderna l’espulsione della contingenza equivale a simulare un adempimento che l’arte non può anticipare rispetto alla società in cui si afferma.

Certo, oggi abbiamo sotto gli occhi molti esempi di una produzione pseudo-estetica che a prima vista parrebbero realizzare proprio lo splendido sogno della clava tlingit, il sogno, cioè, dell’unificazione di segno, immagine e funzione. Sono i prodotti dell’industrial design, e in genere tutti i prodotti tecnologici, nella cui compattezza si direbbe che davvero la contingenza e l’evento, in quanto portatori degli impulsi del soggetto, siano stati felicemente sacrificati alla struttura.
Ma in realtà, quel che in essi si realizza è cosa ben diversa e mistificatrice: vi si attua, essenzialmente, non già la reciproca integrazione del simbolo e della funzione attraverso un processo in cui abbia qualche parte un’effettiva energia formatrice, e, soprattutto, in cui l’espulsione dell’evento e la scomparsa del soggetto-artefice nel prodotto corrisponda a una reale ed organica assimilazione di quest’ultimo alla totalità socio-culturale in cui egli opera, bensì la celebrazione tendenziosa della funzione stessa come tale in quanto Valore assoluto (e conseguentemente, del sistema, che è appunto un sistema prammatico e funzionalista), mediante l’impiego di quelle qualità sensibili (levigatezza, trasparenza, lucidità, linearità, etc.), che ormai, per convenzione, al più elementare livello della comunicazione automatica e riflessuale, vengono percepite non già come immagini, ma come meri segni dell’universo neotecnico.
Il soggetto che scompare in essi non si affida dunque a una presunta comunità reale che lo integri in se stessa accogliendone tutte le potenzialità, ma si consegna mani e piedi a un ordine che si limita a impiegarne ai propri fini le capacità atomizzate.
Proprio perciò quegli oggetti, come del resto tutti i prodotti in cui il sistema si prolunga e si autoriconosce, oltre che svolgere onestamente la loro semplice funzione pratica, ne assolvono un’altra essenzialmente ideologica.In virtù del fatto che il sistema di cui essi esaltano i valori di pretesa razionalità e funzionalità resta un sistema basato sulla violenza, il loro canto si rovescia subito in menzogna.
Fraudolento è il loro tentativo di fingere, nel bel mezzo della società scissa e alienata, la pacificazione universale ed il consenso reale che la loro vana perfezione pretende di rispecchiare, mentre in effetti si limita ad espellere qualsiasi impulso ostile al sistema. Non l’unificazione reale della società si riflette in essi, ma semplicemente la strapotenza indisturbata del cosmo tecnologico, della falsa universalità che parla attraverso di essi e di cui essi svolgono l’apologia ininterrotta.
4
Il riferimento al contrasto fra la teoria adorniana e la vecchia tesi meccanico-materialistica del Semper è illuminante per più di un aspetto. Qui ci limiteremo a richiamarci nuovamente ad esso per mostrarne la rilevanza ai fini dell’esatto intendimento di una categoria estetica fra le più problematiche e controverse: il concetto di stile.
Il Semper, come si è visto, postulando la priorità storica del geometrismo ornamentale e stilizzatore sul naturalismo mimetico, giunge implicitamente ad affermare il primato estetico della stilizzazione sul principio imitativo.
Per lo Hauser, invece, l’arte acquista un carattere simbolico-geometrico solo dopo il passaggio all’età neolitica, che vuol dire anche transizione da un’economia di consumo a un’economia di sussistenza, dalla magia empirica al culto ritualizzato, dal monismo magico al dualismo animistico, dall’individualismo primitivo dell’orda cacciatrice al conservatorismo autocratico del dominio basato sulla stabile proprietà agricola. Il formalismo geometrico ha insomma basi economiche radicalmente diverse e storicamente posteriori a quelle del naturalismo neolitico.Ѐ evidente che dall’accertato primato del principio mimetico rispetto al momento della stilizzazione nel movimento storico dell’arte derivano conseguenze di grande rilievo.
Ora tali conseguenze coincidono in sostanza con la splendida critica del concetto di stile che Adorno tratteggia nel suo saggio sull’industria culturale.
Egli parte da un esame di quella caricatura del vero stile che è lo stile dei prodotti dell’industria culturale. I superficiali lamenti sull’estinzione dell’energia stilistica nella civiltà di massa gli sembrano affatto infondati. E infatti, l’odierna traduzione stereotipa di tutto, compreso ciò che non è stato ancora pensato, nello schema della riproducibilità meccanica, supera in rigore e validità ogni vero stile.
Nessun Palestrina avrebbe saputo espellere la dissonanza impreparata e irrisolta col purismo con cui un arrangiatore di musica jazz elimina ogni cadenza che non rientra perfettamente nel gergo. Nessun costruttore di chiese del Medioevo avrebbe passato in rassegna i soggetti delle vetrate e delle sculture con la diffidenza con cui la gerarchia degli studi cinematografici esamina un soggetto di Balzac prima che questo ottenga l’imprimatur di ciò che può andare.
Il catalogo esplicito e implicito, essoterico ed esoterico, del proibito e del tollerato, non si limita a circoscrivere un settore libero, ma lo domina e controlla da cima a fondo. Anche i minimi particolari vengono modellati alla sua stregua. L’industria culturale, attraverso i suoi divieti, fissa positivamente — come la sua antitesi, l’arte avanzata — un suo linguaggio, con una sintassi e un lessico propri.
La necessità permanente di nuovi effetti che restano tuttavia legati al vecchio schema, non fa che accrescere, come regola suppletiva, l’autorità del tramandato, a cui ogni singolo effetto vorrebbe sottrarsi. Tutto ciò che appare è sottoposto a un marchio così profondo che, alla fine, non appare più nulla che non rechi in anticipo il segno del gergo e non si dimostri, a prima vista, approvato e riconosciuto.
Siamo perciò di fronte a una stilizzazione la cui forza vincolante si riferisce a sfumature così sottili da raggiungere quasi la raffinatezza di mezzi di un’opera d’avanguardia, con cui peraltro questa ultima, al contrario di quella, serve alla verità.
A oltre vent’anni dall’epoca in cui fu scritto, il saggio di Adorno conserva anche in questa parte tutta la sua efficacia. Gli ulteriori progressi compiuti negli ultimi decenni dalla capacità stilizzatrice dell’industria culturale (la quale è dunque ben altro che il « caos » denunciato dai tardi e impotenti avvocati di un umanesimo arcaico ed ignaro), hanno largamente confermato le tesi anticipatrici di Adorno.
La « purezza » stilistica dei prodotti più recenti dell’industria culturale appare più irrefutabile di quella già esibita dai meno perfetti esemplari degli anni trenta. Innegabile, ad esempio, è la superiore omogeneità formale dei « kolossal » di David Lean (Il ponte sul fiume Kwai, Lawrence d’Arabia, Il dottor Zivago) o dei films di James Bond rispetto ai loro equivalenti d’una volta, anche quando recavano la firma di un manipolatore esperto ed efficiente come Cecil B. De Mille.
Il grado di fusione dei suoi disparati elementi che il « musical » di Broadway sa oggi realizzare, e in cui vengono assorbiti, accanto ai tradizionali ingredienti di origine popolare, persino alcuni fermenti della musica d’avanguardia e del balletto moderno (la coppia Robbins-Bernstein rivela in ciò una sapienza ineffabile), è quasi sorprendente rispetto alle goffaggini ed alle impurità che il « genere » conosceva ancora ai tempi di Ziegfeld e di Cole Porter, quando in esso gli elementi dilettantistici ed eccentrici dell’amusement popolare non erano stati del tutto addomesticati o liquidati. L’abilità, infine, con cui un narratore di « serie B » dei giorni nostri (sia esso il Truman Capote di A sangue freddo o il Bevilacqua di Una specie di amore) riesce ad imprimere un calco formale uniforme ai materiali preselezionati, onde ottenerne quel che si dice « un congegno narrativo » che funzioni, supera di mille cubiti i conati stentorei e impacciati della famigerata narrativa ungherese dell’entre-deux-guerres o delle nostre coeve De Cespedes.
Ma quel che conta ai fini del nostro discorso, è che questa caricatura dello stile dice qualcosa sullo stile autentico del passato. Il concetto di stile autentico si smaschera, nell’industria culturale, come equivalente estetico del dominio. L’idea dello stile come pura coerenza formale è una proiezione retrospettiva dei romantici.
Nell’unità dello stile, non solo nel Medioevo cristiano, ma anche nel Rinascimento, si esprime la struttura di volta in volta diversa della violenza sociale, e non l’oscura esperienza dei dominati, in cui era racchiuso l’universale. I grandi artisti non furono mai quelli che incarnarono lo stile nel modo più puro e perfetto, ma quelli che accolsero nella propria opera lo stile come rigore verso l’espressione caotica della sofferenza, come verità negativa.
Nello stile delle opere l’espressione acquistava la forza senza cui l’esistenza si perde inascoltata. Anche le opere che passano per classiche contengono tendenze oggettive che sono in contrasto col loro stile. Fino a Schönberg e Picasso, i grandi artisti hanno conservato la diffidenza verso lo stile, e — in tutto ciò che è decisivo — si sono tenuti meno allo stile che alla logica dell’oggetto. Ciò che dadaisti e surrealisti affermavano polemicamente, la falsità dello stile come tale, trionfa oggi nel gergo canoro del crooner, nella grazia colta a puntino della star e, infine, nel magistrale colpo fotografico sulla capanna miserabile del bracciante.
In ogni opera d’arte, lo stile è una promessa. In quanto ciò che è espresso entra, attraverso lo stile, nel linguaggio musicale, pittorico, verbale, dovrebbe riconciliarsi con l’idea della vera universalità. Questa promessa dell’opera d’arte di fondare la verità attraverso l’inserzione della figura nelle forme socialmente tramandate, è necessaria e ipocrita a un tempo. Essa pone come assolute le forme reali dell’esistente, pretendendo di anticipare l’adempimento nei suoi derivati estetici. In questo senso, la pretesa dell’arte è anche sempre ideologia.
D’altra parte, è solo nel confronto con la tradizione che l’arte può trovare un’espressione per la sofferenza. Il momento, nell’opera d’arte, per cui essa trascende la realtà, è in effetti inseparabile dallo stile; ma non consiste nell’armonia realizzata, nella problematica unità di forma e contenuto, interno e esterno, individuo e società, ma nei tratti in cui affiora la discrepanza, nel necessario fallimento della tensione appassionata verso l’ identità.
Anziché esporsi a questo fallimento, in cui lo stile della grande opera d’arte si è negato da sempre, l’opera mediocre si è sempre tenuta alla somiglianza con altre, al surrogato dell’identità. L’industria culturale, infine, assolutizza l’imitazione. Ridotta a puro stile, ne tradisce il segreto: l’obbedienza alla gerarchia sociale.
Lo stile divinizzato dalle estetiche reazionarie (e qui le vecchie tesi del Semper sul primato della stilizzazione sembrano esprimere quella inesauribile tendenza alla restaurazione neoclassica che attraversa, riaffiorando ad intervalli regolari, tutto il cammino dell’arte moderna, in una oscillazione pendolare di cui lo strutturalismo cerca invano di cogliere il significato riducendolo alla mera esposizione nel tempo di una specie di diagramma eterno dello spirito, e così svuotandolo del tutto di contenuto storico), finge dunque mendacemente una conciliazione rabberciando quella frattura fra soggetto e oggetto che la vera opera d’arte non occulta mai.
Lo stile puro e perfetto è essenzialmente ideologico, laddove l’arte è « vera » conoscenza. Alle opere che si affidano esclusivamente al principio della coerenza stilistica accade ciò che Hegel rimproverava al pensiero scientifico: sono statiche, non avanzano affatto, e si risolvono in tautologie. Nelle produzioni dell’intelletto astratto, il fondamento è aggiustato in conformità del fenomeno e le sue determinazioni riposano su questo, sicché è certo che il fenomeno vien fuori dritto dritto e col vento in poppa dal suo fondamento o ragion d’essere.Ma con ciò la conoscenza non è avanzata punto: essa si aggira in una differenza di forma, differenza che questa differenza di procedere rovescia e toglie.
Analogamente, lo stile perfetto delle opere mediocri, non dovendo più affermarsi sulla resistenza del materiale recalcitrante, il quale viene al contrario aprioristicamente sussunto nello schema formale, risulta senza valore, in quanto incapace di determinare fra i due poli una qualsiasi tensione: tutti i particolari del quadro, della partitura o della pagina verranno fuori dritti dritti e « col vento in poppa » dallo schema o calco che sovranamente viene loro imposto dall’esterno.
Essenziale all’arte è invece la rottura, l’irruzione dell’Altro che giunge dall’esterno e che induce a manomettere la forma. E in ciò l’arte ha più a che fare con la logica dialettica che con quella discorsiva. Come già per Hegel nella critica del principio d’identità, anche per l’arte la verità è l’Altro, il non immanente che pur sprigiona dall’immanenza. Solo che quest’Altro non può essere rappresentato come superiorità, nobiltà, trasfigurazione, altrimenti diverrebbe di poco conto, decorativa giustificazione del corso del mondo.
E se l’Altro non dev’essere oggetto di traffico vile, esso va ricercato in incognito, presso ciò che si è perduto: dove l’Altro è, naturalmente, la Natura, mentre il suo medium può essere rappresentato, paradossalmente, dallo stesso materiale della tradizione, al quale l’arte spregiudicata continua a rifarsi come a qualcosa che le ricorda le vittime del progresso nel campo che le è proprio; cioè da quegli elementi di linguaggio che sono stati espulsi dal processo della razionalizzazione del dominio sul materiale.
Il concetto di rottura e di irruzione è essenziale per comprendere ciò che Adorno intende per espressione artistica. L’arte, per Adorno, è sempre scandalosa, ma non necessariamente in virtù dell’evidenza delle innovazioni o della radicalità del materiale. Poiché il progressivo dominio del materiale e la razionalizzazione del linguaggio sono gli equivalenti estetici del dominio e della razionalizzazione sociale, tutti gli elementi di linguaggio che in questo processo sono lasciati cadere, esprimono direttamente quella contingenza che il progresso espelle e respinge con odio per la sua stessa impotenza a coinvolgerla e a trascinarla nella propria marcia.
Quegli elementi, dunque, sono il riflesso della vita calpestata, del residuo umano perduto e sepolto al suono delle trombe del progresso, della libertà sconfitta che continua a far sentire il suo lamento. Ma da ciò deriva che il futuro può anche essere anticipato con mezzi passati, poiché immensa è la forza effrattiva di quei tragici avanzi del progresso. Di qui il paradosso di opere scandalosamente moderne e in cui pure è essenziale l’impiego di elementi arcaici ed antiquati, come, per fare due esempi ormai noti, le sinfonie di Mahler o l’architettura di Gaudì.
Quel che importa, in ogni caso, è che il momento mimetico non si estingua nella tautologia della forma repressiva, e perché ciò non accada è essenziale che almeno un elemento del linguaggio sia sottolineato intenzionalmente in modo da trasformarlo in un fattore di disturbo dell’equilibrio della composizione. Ciò accade in maniera esemplare nel sinfonismo mahleriano grazie, soprattutto, alle nuove modalità d’impiego del suono (che impone alla tonalità un’espressione di cui essa non è più di per sé capace, sicché la forzatura stessa diviene espressione), e all’intenzionale insistenza con cui Mahler gioca con lo scambio del genere maggiore e minore, che appunto conferisce a quella musica un comportamento mimetico.
Questa accentuazione di uno o più elementi del linguaggio è ciò che abitualmente provoca l’accusa di manierismo. Ma il manierismo, ad Adorno, sembra tendenzialmente inseparabile dall’espressione artistica, poiché è proprio attraverso di esso che l’espressione si afferma in opposizione dialettica al principio razionale-costruttivo. Manierismo, quindi, sta qui a significare l’accettazione della protesta dell’espressione contro la maledizione che è stata scagliata su di lei.
Quanto più il sistema della razionalità artistica si pietrifica, tanto meno esso concede all’espressione la dimora che le spetta. Perché questa si affermi, occorre perciò dar rilievo veemente a singoli elementi del linguaggio, intensificandoli fino a farne un’idea soverchiante, plasmarli in veri e propri veicoli d’espressione per equiparare la rigidità del sistema circostante. E ancora: il manierismo è la cicatrice lasciata dall’espressione in un linguaggio che già non è più in grado di realizzare un’espressione… ha la precisa funzione di sabotare un linguaggio ormai banalizzato.
Il culto dello «stile» e del «livello» (cioè del grado di razionalizzazione raggiunto dal linguaggio) è ciò con cui la cultura, in quanto ideologia che spaccia per raggiunta la conciliazione, tenta di ridurre l’arte al silenzio, laddove solo grazie alla rottura della forma può farsi strada la voce dell’Altro, del «diverso», del «perduto», che l’arte ha il compito di evocare. Quest’Altro, alla cultura, non può apparire altrimenti che come Inferiore: donde il perenne scandalo dell’arte, che è sempre stata vista, dalla efficiency borghese, come uno sterile indugio presso ciò che è destinato ad essere allegramente travolto.
L’arte, come la compassione, appare sospetta al carattere pratico del borghese, che preferisce a entrambe la «virtù», intesa appunto come fredda capacità di fronteggiare il destino e di irrigidirsi, senza cedimenti, per adeguarsi virilmente alla rigidità del progresso. Inconsapevolmente, il principio della stilizzazione, il livellamento del linguaggio, è il tentativo suicida dell’arte di adeguarsi a sua volta allo spirito dell’efficienza.
Ma l’arte prospera, al contrario, nel clima della frantumazione, in cui si sensibilizza l’elemento scisso, particolaristico, privato e dunque impotente. La moderna frattura fra arte superiore ed inferiore (in cui fin dall’epoca della rivoluzione industriale si è riflesso esteticamente il processo sociale di reificazione e insieme di dissoluzione dei residuati materiali), denuncia appunto la impossibilità oggettiva di quel livellamento che si vuol realizzare nell’opera.
L’arte, che aspira pur sempre alla sintesi, non può dunque affermarsi indipendentemente da un principio di rivolta contro le « forme superiori », così come non può irretirsi nel mito a cui soggiace l’arte conservatrice, che nella sfera inferiore vede un fattore primigenio, o la natura stessa, da riprendersi nella sua illesa perfezione astorica insieme alle forme tradizionali in cui s’incarnerebbe. Se da un lato la forma, la misura, il gusto, insomma l’autonomia della forma a cui aspira l’arte superiore, sono marcate a fuoco dalla colpa di coloro che ne escludono gli altri, dall’altro la sfera inferiore non incarna alcunché di primigenio, ma è solo la negativa di una cultura fallita.
Ciò vuol dire, naturalmente, che la via del ritorno è preclusa. Attenersi alla tradizione come tale non è meno funesto del tentativo di adeguarsi al « livello ». Il massimo a cui l’arte può pervenire, dopo aver rinunciato alla spietatezza dello stile intatto, equivalente estetico della violenza sociale, è di attirare disperatamente verso di sé ciò che la cultura non accetta, accogliendolo così, misero, ferito, mutilato, come la cultura glielo trasmette. L’opera d’arte, incatenata alla cultura, vorrebbe spezzare la catena, mostrar pietà verso quei sordidi resti, allargando fraternamente le braccia, rimescolando i rozzi elementi tratti dalla sfera inferiore come se fossero il lievito di quella superiore, rimobilitando l‘energia, la forza semantica, la drasticità ed evidenza di quei poveri detriti del progresso, sicché la sfera inferiore irrompa in quella superiore con violenza giacobina, e la tronfia politezza dell’idea « media » sia demolita dalla smodata violenza di quei disparati elementi.
Occorre scavare la felicità proibita proproprio nella materia degradata, in un movimento di pietà per tutto ciò che si è perduto, ricorrendo persino a quella potenza della volgarità intesa come fattore sociale che può sospingere l’arte al di là dello spirito in quanto ideologia. Per quanto possa esserne incapace, l’impulso segreto dell’arte vuole eliminare la sovrastruttura, accusandosi di questa inanità piuttosto che irridere (magari coi modi ironici e parodistici del neoclassicismo) il mondo delle immagini perdute ed evocato.
Nulla proibisce che, una volta distrutta la cultura artistica acquisita, degradatasi a ideologia, sia possibile stratificare con i frammenti e i residui mnestici una seconda totalità, in cui la forza organizzativa fa ritornare oggettivamente la cultura contro cui l’arte si ribella senza però distruggerla. L’opera d’arte, insomma, deve oggi ricercare la possibilità di ricostituire una totalità viva dalle macerie del linguaggio reificato, onde aiutare gli uomini a rendersi consci di sé in quanto natura inibita e della propria operosità in quanto ingannevole storia naturale. Vano è parlare di arte laddove la natura che è nell’uomo non diventa memore di sé, spogliandosi della superstizione relativa all’assoluta diversità di uomo e animale.
5
Infine, il concetto di irruzione va integrato con quello di totalità, con il quale il «clima della frantumazione» contrasta solo apparentemente. L’evento, l’impulso isolato, non ha valore né significato. Solo saldandosi nella totalità estetica i momenti parziali sono in grado di esercitare la critica nei confronti della totalità incrinata della società. Altrimenti, quelli che si emancipano dalla legge formale non sono più impulsi produttivi che si ribellano alle convenzioni, ma, proprio nella misura in cui viene loro sacrificata l’unità estetica, diventano essi stessi elementi che congiurano contro la libertà, mostrandosi di nuovo condiscendenti verso l’unità reificata del mondo.
La degradazione che i momenti parziali del linguaggio artistico subiscono cadendo in balia dell’alienazione reificata è descritta da Adorno nel saggio II carattere di feticcio in musica, dove tutto quel che si dice circa l’abbassamento e l’ottundimento a clichés che i momenti parziali del linguaggio musicale conoscono nei trattamenti correnti, vale analogicamente per tutte le altre arti.
Fascino sensorio, oggettività, elemento profano, tutti fattori opponentisi in origine produttivamente all’alienazione reificata, fermenti antimitologici di ogni arte oltre che nella musica, impulsi critici verso la vuota oggettività delle forme consolidate, promossi come elementi indipendenti e isolati, perdono quella forza, quella drasticità semantica che acquistavano in rapporto all’unità estetica, in opposizione alle forme convenzionali criticamente riprese nell’opera, e insomma sospendono la critica per assumere una funzione smorzatrice.
La grande musica dei secoli XVIII e XIX offre esempi innumerevoli di come siffatti elementi possano entrare nell’arte senza che questa si risolva né in essi, né nelle forme alle quali essi si oppongono. Il fascino sensorio, la stimolazione dei sensi, vi entrò ad esempio come porta d’ingresso della dimensione armonica e poi coloristica; la soggettività, l’individualità sfrenata, come veicolo dell’espressione e dell’umanizzazione della musica stessa; la profanità, la frivolezza, la « superficialità », come critica della muta oggettività delle forme nel senso della haydniana decisione per il « galante » invece che per il « dotto ». In questo modo, la sintesi artistica, oltre che conservare l’unità dell’apparenza evitandole di frantumarsi in momenti « gustosi » in senso culinario, manteneva anche, in questa unità e nella relazione dei particolari col tutto che viene prendendo forma, l’immagine di una condizione sociale che era la sola nella quale tutti quei fortunati momenti potevano essere qualcosa di più che semplice apparenza.
Ma nella tarda società industriale, i tradizionali fermenti antimitologici dell’arte, che già furono veicoli dell’opposizione allo schema autoritario, si riducono a testimoniare l’autorità del successo commerciale. Il piacere dell’attimo e quello della facciata variopinta diventano un pretesto per sgravare il pubblico dal pensiero del tutto. Non che quei momenti isolati siano cattivi di per se stessi: è nell’isolamento che essi lo diventano. Da impulsi produttivi si degradano a semplici oggetti della manipolazione del gusto, spogliandosi di quel tratto di insubordinazione che loro ineriva in origine e vincolandosi alla connivenza con tutto ciò che l’attimo isolato è in grado di offrire a un individuo che è a sua volta isolato e da tempo non è più nemmeno un individuo.
È il trionfo del principio dell’ « effetto », che si afferma in maniera manifesta, tanto per fare un esempio accessibile, nell’accentuazione irrelata dell’aspetto materico in pittura e di quello timbrico in musica, perseguita in entrambi i casi in funzione di quella stimolazione « gustosa » che Adorno argutamente definisce di tipo culinario. In musica, particolarmente, questo trasferimento dell’interesse all’allettamento timbrico e al trucco singolo, senza rapporti con l’insieme e con la stessa « melodia », non è certo una rivolta contro la funzione disciplinatrice, e ciò essenzialmente perché gli allettamenti appercepiti restano senza resistenza entro lo schema rigido.
Ma c’è ancora da aggiungere che le reazioni agli stimoli isolati sono ambivalenti, e ciò che può essere sensorialmente gradevole si rovescia in sensazione di nausea non appena ci si accorge che esso serve solo a truffare il consumatore. La truffa consiste nel fatto che viene offerta sempre la stessa cosa. Anche il più ottuso entusiasta di musica leggera non potrà sempre evitare la sensazione familiare al fanciullo ghiotto che esce da una pasticceria. Gli stimoli tendono al loro contrario.
Ma tutto ciò non riguarda soltanto l’arte commerciale. L’infatuazione per il materiale è ormai da tempo un tratto tipico della stessa arte d’avanguardia, ed essa rivela, in pari tempo, il rilassamento della tensione interiore e quello della forza formatrice. Comune sia ai prodotti dell’industria culturale, sia a quelli dell’arte avanzata, è inoltre la stessa tendenza, di cui si è già parlato, a una crescente razionalizzazione del linguaggio. Ad esempio, per quel che concerne la musica, negli eredi della scuola schönberghiana, il materiale compositivo è stato mondato dalle scorie e dai residui del passato, ma resta sempre da chiedersi se questa purificazione da ogni possibile scoria, più che giovare alla musica in sé, non minacci di mettersi al servizio di una mentalità tecnocratica.
La razionalizzazione, in altri termini, giova al fatale depotenziamento di un linguaggio che, da ostile al sistema com’era in origine, proprio grazie ad essa si trasforma in suo complice involontario. In questo senso l’obsolescenza delle forme artistiche non è mai un semplice effetto dell’uso, ma sempre, al tempo stesso, della loro neutralizzazione. Attraverso l’uso si compie la rimozione dell’impulso.
È ciò che Adorno afferma quando osserva, delle sonorità usate ancor oggi dai tardi epigoni della scuola di Vienna, che esse sono rimaste le stesse; ma il fatto dell’angoscia, che aveva dato vita ai suoi primi istanti (della musica dodecafonica), è stato rimosso. Quell’invecchiamento dell’arte moderna che si manifesta, al livello delle forme, nel livellamento del materiale e nell’infatuazione per esso, si esprime poi al livello sociologico nella nota tolleranza di cui essa è diventata oggetto.
L’arte d’avanguardia è ormai ammessa come affare privato di un gruppo di specialisti: pare che sia necessaria alla cultura, non si sa bene perché, e viene lasciata agli esperti. L’infatuazione per il materiale tradisce un fraintendimento radicale del valore di quegli elementi del linguaggio a cui ci si vuole affidare come a momenti isolati. Essi possono essere, sì, veicoli d’espressione, ma solo in senso mediato. I loro valori particolari sono infatti legati in parte alla relazione con gli elementi tradizionali, in parte alla loro posizione nell’insieme della struttura compositiva che essi contribuivano a modificare.
Per amore della loro novità intrinseca, però, le qualità espressive vennero dapprima attribuite ai fenomeni isolati, e da ciò deriva una fede superstiziosa in presunti elementi originari che in verità sono prodotti della storia e sono storici nella loro stessa costituzione. La mentalità artistica radicale non si è mai liberata del tutto da questa superstizione, trasformandosi facilmente in artigianato… Alla base di tutto sta la finzione che il materiale possa parlare da solo, una specie di simbolismo materializzato.
Certo che « parla » il materiale: ma solo nei punti focali in cui vien posto nell’opera d’arte. Schönberg è stato grande fin dal primo giorno per questa capacità, e non solo per aver inventato qualche sonorità singola. Invece la sopravvalutazione del materiale, che si mantiene pervicacemente in vita, induce a credere che l’allestimento di materie prime musicali sia né più né meno che musica. Nella razionalizzazione si cela un pessimo fattore irrazionale, la fiducia cioè che una materia astratta possa avere un significato in se stessa: ed è invece il soggetto che si misconosce in essa, mentre esso solo potrebbe cavarne un senso.
Il soggetto è accecato dalla speranza che quelle materie possano sottrarlo alla cerchia magica della propria soggettività.
Alla fiducia nella facondia intrinseca del materiale se ne unisce un’altra: quella di trovare qualcosa che, simile a zone neutre, a nevi vergini, permettesse una pura immediatezza, libera dalla pressione del soggetto e dalla reificazione delle sue vestigia in espressione convenzionale. Tale fiducia esprime, da ultimo, quell’allergia oggi molto diffusa per ogni forma di espressione. È tuttavia sbagliato equiparare « espressione » con « romanticismo », come si tende a fare con un’asserzione che dà a quella ripulsa l’apparenza dell’avanguardia modernista.
Esorcizzata l’arte dall’espressione in quanto tale, non restano che arazzi di forme in movimento, visto che si è logorato, nell’espressione, il momento trasfiguratore, l’elemento ideologico… Bisognerebbe ridare all’espressione la densità dell’esperienza, come già si era tentato nella fase espressionista, mentre non serve a nulla seguire il culto dell’inumanità invece della parvenza rituale dell’umano. E qui giungiamo a sfiorare un motivo antropologico fondamentale.
Dall’odierna ostilità per l’espressione, Adorno trae la conclusione che l’angoscia possa aver acquistato un tale predominio nella vita reale da rendere insopportabile la sua immagine… L’angoscia e il dolore sono cresciuti fino all’estremo, e l’anima del singolo non riesce più a soggiogarli. L’idiosincrasia per l’espressione — che è tutt’uno col dolore — nasconde questo desiderio di allontanamento, e non l’aspetto positivo di una condizione, ritenuta superiore, di pudore e autodominio.
L’attuale paralisi delle forze artistiche rispecchia pertanto la paralisi di qualunque iniziativa libera in un mondo amministrato che nulla tollera al difuori di sé a meno di integrarlo come fenomeno di opposizione autorizzata. Lo stesso individuo, anche e soprattutto in quanto soggetto-artefice, diventa oggetto passivo di questa integrazione che ribadisce la sua dipendenza.

La differenziazione casuale di dettagli e sfumature irrilevanti nell’ambito della produzione artistica razionalizzata finisce per liquidare definitivamente quell’individualità che il mercato deve fingere di promuovere nel momento stesso in cui la neutralizza, occultando l’uguaglianza a cui mette capo la manipolazione del gusto con l’esibizione di tratti differenziali esteriori fra un autore e l’altro, cui si accompagna il culto feticistico della falsa individualità .
In questa stretta l’arte vuole infine tentare di salvarsi con quella goffa mimesi di procedimenti scientifici che sembra oggi sedurla; ma il tentativo equivale a un suicidio, poiché se ci si scorda che l’arte, oggi come ieri, occupa una zona separata da quella dei nessi d’interazione pratica, sì che non può essere partecipe di questo aspetto della tecnica, allora essa diventa un’altra cosa ancora, né arte né tecnica, qualcosa di peggiore, esteticamente vuoto e impotente in realtà: un prodotto dilettantesco e tecnicistico pieno di pretese. Il disperato miraggio dell’arte di potersi salvare in un mondo così disincantato adeguandosi in tutto alla scienza, diventa una grave calamità: è un gesto che in psicologia viene chiamato «identificazione con l’aggressore… » .
Si torna così alla dialettica di mito e scienza, lavoro e dominio, dove la scienza diventa mito e l’arte, opponendosi al mito scientista, si rovescia in conoscenza migliore della scienza; opponendosi alla falsa unità della totalità incrinata del mondo, accoglie in se stessa il compito storico di delineare la verità e la salvezza; ma dove essa può anche, nel proprio isolamento che l’acceca, subordinarsi a un principio che le è ostile da sempre nella infelice mimesi non già della vita, ma delle procedure e delle tecniche di quella scienza che si è sviluppata non per la conoscenza della vita, ma per il suo semplice «uso ».
Ciò non può non irritare una cultura avvezza a distinzioni rigide, al pensiero lubrificato che agogna gli incasellamenti e le partizioni coatte per meglio amministrare lo spirito scisso e diviso in settori. Che ha a che fare l’arte con l’Aufklärung? Ma l’interrogativo, che mira a separarla dal processo dell’illuminismo, quasi fosse una riserva naturale di immutabile umanità e confortevole immediatezza, tende perciò stesso a perpetuare la separazione barbaro-borghese di intelletto e sensibilità.
tratto dal numero 9


